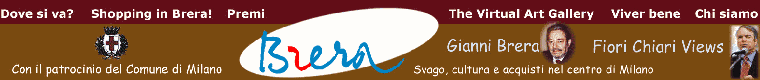
|
||||||||
Benvenuti nel club dei Senzabrera (Introduzione al libro Giôannfucarlo) Dimentichiamo in fretta. Gli uomini, soprattutto. Meno male, verrebbe voglia di dire, visto che i pochi di cui si conserva memoria vengono incapsulati dentro ermetiche antologie o frettolosi reliquiari omnicomprensivi, con un processo di liofilizzazione che ne offende lo spessore umano, ne oscura la fatica e il sapore del rispettivo vivere quotidiano. Peggio ancora se poi, con tardivo slancio creativo, si vuol rendere omaggio a qualche grande del passato rivisitandone l'esistenza attraverso gli schemi del romanzo storico, con ricostruzioni arbitrarie e fantasiose. Bruno Pizzul Suppongo che gli autori di questo lavoro su Gianni Brera abbiano, magari inconsciamente, voluto scongiurare simili rischi, regalando, soprattutto a quanti non lo hanno frequentato di persona, le coordinate per comprenderne lo spiritaccio indomito e la singolare vocazione alla parola scritta. Non di biografia classica si tratta, né di sistematica e ordinata raccolta antologica, ma piuttosto di testimonianza che nasce dalla toccante pietas filiale di Paolo e dalla fede breriana di Claudio Rinaldi, protagonista di mistico giovanile pellegrinaggio per incontrare nelle Cinque Terre il grande Giôann. Freschi d'affetto e di ricordo ci raccontano quasi in presa diretta1'uomo, il padre, il giornalista, il primattore. Dio mi scampi, comunque, dalla tentazione di fare esercizio di critica letteraria sulla fatica di Brera fu Giovanni e Rinaldi. Ci mancherebbe altro. Abituato, per ancestrale pigrizia soggettiva, a fidarmi del gusto personale, posso solo dire di aver tracannato con avido piacere lo scritto: inorridiscano pure i critici di professione che considerano peccaminosa ogni valutazione di natura soltanto edonistica. A me il lavoro a due mani è piaciuto e tanto mi basta. Leggere per credere. Affascinante mi è parsa soprattutto l'indicazione del processo evolutivo attraverso il quale Gianni Brera è arrivato a perfezionare il suo stile: sono riportati alcuni testi giovanili che mai e poi mai avrebbero lasciato supporre maturazione di linguaggio e capacità comunicativa tanto singolari. Ma basta là con queste maldestre acrobazie interpretative, meglio è forse che io butti giù due parole sul Brera che ho conosciuto e frequentato, ahimè molto meno di quanto avrei voluto. Mi sono spesso chiesto da che cosa nascesse la sua bonomia nei miei riguardi, visto che ci incontravamo di rado. Credo che mi abbia battezzato bene al nostro primo incontro. Stavamo l'uno accanto all'altro al ristorante, lui già celebre Gioanbrerafucarlo, io appena arrivato alla rai, autentico signor nessuno. Ero però già apparso in tv per qualche banale intervistucola e telecronaca estiva. A un certo punto ci si avvicinò un pinella e mi chiese l'autografo, ignorando completamente l'augusto commensale che mi stava al fianco. Arrossii violentemente per l'imbarazzo e implorai perdono con gli occhi. Gianni capì subito la faccenda e con gesto magnanimo mi trasmise il messaggio: firma e sta' zitto, non è colpa tua, semmai è colpa del lavoro che fai tu e che faccio io. Subito dopo prese a conversare con me in modo più amichevole e a interrogarmi sulle mie origini. Lombardo non ero, ma la radice friulana era sufficiente a conferirmi buone possibilità di accettazione quanto a etnos e trascorsi gravami sociostorici. Quando poi seppe che ero figlio del macellaio del paese, che avevo nutrito sogni calcistici mai compiutamente realizzati, che ero arrivato in rai quasi per caso, che mi ero laureato giochicchiando qua e là per l'Italia, che ancora non ero sicuro di aver imboccato la strada giusta, mi fece ulteriormente salire nella sua considerazione. Per la verità emerse subito anche qualche piccolo contrasto d'opinioni. Colpa del vino. Gianni era gran cultore dei rossi e, verificato che io andavo solo a bianco, tentò di convertirmi quanto meno a più canonici accostamenti con la mangeria: sorseggiai per compiacerlo qualche gotto di barbera ma poi mi rituffai nel per me più familiare e rassicurante tocai. Del quale invano cercai di tessere le lodi: bisogna dire che allora, ultimi anni Sessanta, i miei amici produttori del Collio non erano ancora riusciti a imporre a livello nazionale il loro prodotto e quindi giocavo in chiara inferorità anche di mercato contro cotanto avversario. Tenni però duro e Gianni apprezzò quella dimostrazione d'attaccamento alle radici, bollando la mia testardaggine con un solo apparentemente velenoso "mona de un furlàn". Lo aveva senz'altro imparato da Rocco, che da buon triestino era solito apostrofare così noi contadinotti della Piccola Patria Friulana. Indimenticabili gli incontri tra Rocco e Brera, di cui resta traccia anche nella cineteca rai: Gianni Minà li mise uno accanto all'altro a Trieste e ne uscì un documento straordinario di umanità e maestria comunicativa. Più ancora era gradevole stare con loro a tavola, quando non c'era l'urgenza del servizio da confezionare e, tra giornalisti e uomini di sport, esisteva ancora un rapporto confidenziale, si poteva parlare a ruota libera. Quei due avevano tutto per andare d'amore e d'accordo: anche Nereo viaggiava preferibilmente a rosso, si intendevano alla meraviglia su quello che era il calcio adatto a noi italianuzzi, amavano la buona tavola e la compagnia, sparacchiavano a destra e manca giudizi terribili su chi non andava loro a genio. Argomento privilegiato il pallone, anche se Brera era diventato un magico cantore dell'atletica, del ciclismo, del pugilato. Ma per averli studiati e scoperti, prima di parlarne. Vuoi mettere il fascino sottile e innato del "folber"? Lo trasmette alla sua maniera Gianni Brera in ripetute professioni d'amore per questo sport inventato sì dai borghesi, ma diventato patrimonio anche dei poveri, elevato nel suo sentire quasi a espressione d'arte quando la fantasia si accoppia all'abilità. "Grande sarà la tua gioia quando parlerai alla palla con le mani che l'uomo, camminando per milioni di anni, ha trasformato in piedi", sentenzia. Rocco, al proposito, non aveva bisogno di venir convinto e, semmai, si sforzava di arricchire con nuovi argomenti concreti le tesi del Giôann: lo portai, dopo molte insistenze, a vedere una partita di pallacanestro tra l'allora grande Simmenthal e il Real Madrid, roba di lusso, per la coppa dei campioni. Alla fine gli chiesi un parere su quella che lui si ostinava a chiamare palla al cesto. "No xé mal, ma i fa sempre falo de man". Venuto a conoscenza di questa definitiva risposta, Brera si premurò di far arrivare al Paròn i suoi complimenti: usare le mani per giocare è come annullare 1'evoluzione del bipede umano che tanto ha penato per poter alfine usare i piedi, che una volta erano mani, come strumento di gioco. Anzi d'arte. Le sparavano grosse quando erano assieme quei due, contenti di potersi esprimere nelle rispettive parlate natali, fingendo perfino di comprendersi sempre, anche se Rocco ogni tanto, sottovoce, mi chiedeva: "Cossa el gà dito?". Già, Brera e il dialetto. Ne rivendicava convinto alcune peculiarità espressive intraducibili, partigiano il giusto per il suo lombardo bassaiolo ma pronto a riconoscere analoghe potenzialità anche ad altre parlate. Fu molto colpito quando gli dissi che, nella sola parte del Friuli Venezia Giulia rimasta per secoli sotto gli Asburgo, le scarpe da calcio venivano chiamate "tretars" o "tretari". Vocabolo apparentemente misterioso, visto che nessun dizionario tedesco lo riporta e sconosciuto già ai friulani di Udine. Mi invitò anche a usarlo in telecronaca, in sostituzione del classico "scarpe bullonate" o del vezzoso ma decisamente comico "scarpini", buono per la Fracci ma non certo per rudi "prestipedatori", come li chiamava lui. Me ne guardai bene, era solo suo il diritto a inventare parole nuove. Di recente, ammesso che a qualcuno interessi, l'esimio professor Frau, dell'Università di Udine, mi ha comunicato trattarsi effettivamente di un tedeschismo goriziano, derivante dalla lingua gergale dei soldati che chiamavano "treter" le loro scarpe da fatica, con le quali evidentemente prendevano a calci il pallone. Fosse venuto a saperlo il Gianni, ci avrebbe di sicuro ricamato un trattato, anche per scovarvi le ragioni dell'inziale supremazia calcistica della scuola danubiana: non risulta infatti che i soldati del Regio Esercito Italiano avessero, a quei tempi, un paio di scarpe di riserva con le quali poter prendere a pedate un pallone. Per non parlare del pallone stesso. Del calcio il Nostro era cultore appassionato e attento osservatore. Per trattarlo e, alla sua maniera, ha dovuto diventare direttore della Gazzetta, prima gli avevano fatto scrivere di atletica e di ciclismo. Lo fece tanto bene che ben presto lo misero a capo della congrega. E finalmente potè parlare anche di pallone. Con la forma e i contenuti preferiti. A dispetto delle apparenze, Gianni non era un vanaglorioso, gli piaceva sì raccontare a tavola o nei celebri Arcimatto l'antico suo mondo paesano ai margini di Po, la fatiche per assicurarsi il lesso, le strizze col paracadute, i fugoni e le imprese da partigiano, ma lo faceva senza andare sopra le righe, spesso dando l'impressione di non prendersi troppo sul serio, per quanto drammatici fossero gli eventi. Rimase invece sempre fiero della personale crociata, come direttore della Gazzetta, per bandire dal calcio italiano l'imperante e deleterio wm. Passò per eretico bestemmiatore, affossatore dello spettacolo, becero difensivista. Rispose naturalmente per le rime, circondato dai pochi fidi pretoriani che s'era scelto. Fu un periodo fecondo per il giornalismo sportivo italiano: di pallone si cominciò a parlare in modo serio, non più da fini scrittori che non conoscevano il calcio nè da vecchi pallonari che non sapevano scrivere. Mi raccontò più volte di quelle vicende e di come trovò alleati preziosi in alcuni tecnici nostrani che finalmente cominciavano a emanciparsi dalla sudditanza verso la scuola inglese o danubiana. Partiva da argomentazioni di carattere etnico e nutrizionale per affermare l'inapplicabilità di schemi troppo dispendiosi al nostro calcio di italianuzzi striminziti e muscolarmente flebili: tesi che poteva anche non essere condivisa. Ma nella sostanza tattica aveva ragione da vendere, lo hanno dimostrato i fatti: senza cavillare troppo, ogni volta che, nel calcio di oggi, dalla matassa aggrovigliata del centrocampo schizza fuori un pallone e una squadra si trova a proporre l'azione d'attacco in parità numerica con i difensori avversari, noi telecronisti alziamo il tono della voce come se si trattasse di gol già fatto. Con il wm era la norma: due terzini e un centromediano contro le due ali e il centravanti, roba da matti. Il calcio italiano ci sarebbe arrivato lo stesso, ma Gianni Brera gli diede una bella svegliata e per farlo fu costretto a battagliare non poco con i benpensanti dell'epoca. E furono battaglie giornalisticamente feroci, al confronto le più recenti tenzoni originate dall'avvento nel pianeta calcio (brerarianamente Eupalla) del "guru" Righetto Sacchi, scadono al rango di semplici scaramucce ricamate in punta di fioretto. Allora non si determinarono due schieramenti critici contrapposti, la sproporzione quantitativa delle forze in campo risultava clamorosa: il prode fracassone Brera e i suoi pochi fidi contro tutti. E furono botte da orbi. Che poi Brera conducesse questo "bellum pedatorium" come direttore, giovanissimo, della Gazzetta scatenò la rabbiosa reazione di tutti i concorrenti, compatti nell'osteggiare chiunque ardisse farsi paladino della spregevole nuova eresia difensivista. E pensare che, almeno in parte, altro non era che un ritomo al "metodo" che prevedeva una linea di quattro difensori, con due terzini centrali. Adottandolo, la nazionale italiana negli anni Trenta aveva vinto due mondiali e un'Olimpiade, con alla guida il mitico Vittorio Pozzo che pure, dicono, si segnalava più per i discorsetti gonfi di amor patrio negli spogliatoi che per acume tattico in panchina. Poi quel modo di giocare calcio fu abbandonato per far posto allo squilibrio del wm, considerato il punto d'approdo finale dell'evoluzione pedatoria. Attento osservatore, Brera aveva però notato che, senza strombazzamenti, alcuni tecnici avevano preso a puntellare la difesa con l'arretramento di un uomo: Viani nella Salernitana, Rocco nella vecchia Triestina, in campo internazionale il viennese Rappan alla guida della Svizzera con il famoso "verrou". E l'Inter di Foni aveva vinto due scudetti di seguito (1953 e 1954) liberando Blason alle spalle del centromediano ormai avviato a diventare "stopper". Ma sostenere e propugnare quel piccolo stratagemma tattico in maniera aperta come faceva Brera divenne per i pretesi esteti del pallone una diabolica infamia. Catenaccio, libero, difensivismo si trasformarono in parolacce con le quali additare al pubblico disprezzo i monatti che pretendevano diffondere il nuovo veleno al fine di strangolare la sacrale bellezza del calcio. Che poi dietro questo frastuono di polemiche ci fossero motivi non tanto legati alla filosofia del pallone ma bassi interessi di bottega, è altro discorso. Talmente cieca e rabbiosa fu la reazione che perfino Foni, arrivato alla guida della nazionale dopo i due scudetti nerazzurri conquistati con tanto di libero, impose masochisticamente agli azzurri il wm con il solo risultato di mancare la qualificazione ai mondiali 1958: eliminati dall'Irlanda del Nord, formazione di cui i vari Ghiggia, Schiaffino, Pivatelli, Montuori, Da Costa, solo per citare il reparto avanzato, avrebbero dovuto fare un solo boccone. Amarissima esperienza per il calcio italiano (si fa per dire, visto che gli italiani "veri" in quella nazionale erano ben pochi), ma prezioso puntello per la missione del Giôann, nel frattempo passato al Giorno. Di quel periodo e di quelle furibonde baruffe Brera parlava volentieri nelle confessioni scritte e nei conversari conviviali, certo di aver proprio allora irrobustito la naturale "vis polemica", arma attraverso la quale ha poi sempre continuato a deliziare i lettori e imbufalire le vittime. A rileggere oggi certe sue filippiche, senza avere l'esatta percezione del clima che s'era instaurato, ci si può meravigliare per l'asprezza dei toni e la violenza del linguaggio, ma il Giôann, superata la fase della giovanile prudenza quando l'esigenza primaria era quella di assicurarsi il lesso, si trasformò in polemista formidabile, tutto d'attacco. Un difensivista come lui? Nulla di strano: nel calcio predicava cautela perché gli altri erano o potevano essere più dotati nella corsa, nel muscolo, nel supporto atletico; quando si trattava di giocare o far la guerra con le parole intuiva di essere il più forte, andava all'attacco perché sapeva di avere in mano le carte migliori. Certo è che da quella stagione uscì di molto cambiato non solo il calcio ma anche e soprattutto il giornalismo sportivo italiano. O, meglio, la considerazione che gli altri avevano del giornalismo sportivo. Al proposito si può ben dire che Brera rappresenta per la sua categoria professionale quel che per gli allenatori hanno rapresentato Rocco ed Herrera. Prima del paròn e del mago i tecnici erano personaggi sfumati per il grande pubblico, se ne parlava poco, nemmeno nella fucina dei ricordi se ne trova traccia. Di mitici squadroni vincenti ancor oggi si recita, quasi come litania, la formazione: Bacigalupoballarinmaroso... ma chi era l'allenatore di quei grandi scomparsi nel rogo di Superga? Chi il tecnico della Juventus il cui incipit era Combirosettacalligaris? Dalla grande esibizione di hh e Nereo triestin, impagabili teatranti, abilissimi in panchina e più ancora nella pantomima della sbandierata rivalità personale, l'intera categoria degli allenatori ha ricevuto prestigio, fama e grande visibilità. Più o meno lo stesso ruolo di volano ha assunto Brera per il giornalismo sportivo: non che prima di lui non ci siano stati validi rappresentanti, ma, nel contesto del microcosmo informativo, occupavano un rango marginale, quasi di serie B, anche quando si riconosceva a qualcuno di loro proprietà di linguaggio o ricchezza di competenza. Sarebbe naturalmente sbagliato affermare che Brera, da solo, ha consentito questa singolare metamorfosi categoriale: di sicuro c'è che, arrivato sulla scena con l'impeto di un ciclone, ha coinvolto anche i colleghi, amici o nemici che fossero, a un diverso approccio con il mestiere, a un più incisivo e magari arrabbiato modo di confrontarsi ed esprimersi. Molto più popolari oggi allenatori e giornalisti, molto più ricchi solo i primi. Ma di questo non si può incolpare Brera che, per parte sua, una volta diventato "Brera", poteva infischiarsene del contratto collettivo di lavoro, era in grado di dettare le proprie condizioni ai molti che ambivano retribuirlo, anche sapendo che mai lo avrebbero potuto irretire dentro vincoli editoriali di ideologia o di maniera. Come sempre avviene quando si parla di chi è andato avanti, per dirla al modo degli alpini che salutano così i loro morti, c'è il rischio di imbastire processi di laica beatificazione, affastellando solo meriti e virtù del celebrato. È un esercizio che finisce il più delle volte per rendere un cattivo servizio proprio al caro estinto, che ne esce edulcorato e privo di sostanza. Dire, per esempio, che Gianni Brera sia stato un esemplare della progenie umana privo di difetto alcuno sarebbe un insulto, a lui prima ancora che alla verità. Anzi, proprio lo spessore della carne e il conseguente umore sanguigno lo facevano dispettoso e vendicativo, narciso come deve essere chi cose e convinzioni non per sé solo vuol tenere ma pure comunicarle agli altri, testardo anche contro l'evidenza nel sostenere le prorie tesi. Perché mica sempre aveva ragione, come nel caso del wm: prendeva anche topiche clamorose, soprattutto per la presunzione di voler collegare sempre e comunque il rendimento sportivo alla radice etnica, nutrizionale, sociale e territoriale del singolo atleta. Colpito dalle prime apparizioni tra i professionisti di Eddy Merckx, con alcune folgoranti vittorie in corse di un giorno, sentenziò che mai e poi mai il fiammingo avrebbe primeggiato in un Giro o in un Tour, per il semplice motivo che lui e gli avi suoi poca pastasciutta avevano mangiato e il conseguente deficit di carboidrati non avrebbe consentito al ragazzo i recuperi immediati necessari per vincere una grande corsa a tappe. In lui vedeva, insomma, un nuovo Van Steenbergen o Van Looy o De Vlaeminck, immensi interpreti delle gare d'un giorno. Merckx, invece, divenne il Cannibale e si mangiò tutti, Brera compreso, in un solo boccone o a tappe. Se poi gli capitava, tirato per i capelli, di iscrivere un malcapitato nel registro dei nemici personali lasciava scatenare la vena polemica e menava botte da orbi, magari non solo con le parole. Ma una sola volta, pare, ci scappò in tribuna un cazzottone a uno storico rivale. In compenso gli succedeva spesso di non resistere alla tentazione per qualche battutaccia anche nei confronti di chiunque si avventurasse dalle sue parti. Una volta osai schiacciare un interruttore per accendere la luce, visto che arrivava il buio: il Giôann, con il quale ci trovavamo in combriccola, fingendo meraviglia per la riuscita della mia impresa, soffiò in lombardo stretto che non mi azzardo a riprodurre: "Però! Questi friulani si sono civilizzati in fretta". Gli risposi che la sua celebrata Pavia longobarda aveva ricevuto l'investitura dalla friulana Cividale e lui subito abbozzò soddisfatto, ridacchiando. Amava anche punzecchiare l'irascibile Nicolò Carosio, cui per altro voleva un gran bene, ferendo il suo orgoglio di giocatore a scopone: il perfido bassaiolo fingeva di professare grande ammirazione per il metodo perfetto con cui il grande radiocronista palermitano perpetuava i propri errori, sempre gli stessi. Ci voleva molto meno per incendiare Carosio e ne scaturivano sistematici, chiassosi ma incruenti litigi. Di Gianni Brera era straordinaria la cultura generale ma soprattutto storica, tanto più sorprendente in quanto gli studi giovanili erano stati piuttosto disordinati, visti anche i tempi. Segno di una successiva applicazione personale, portata avanti, par di capire, in costante coordinazione con il lavoro giornalistico. Non c'era posto in cui il mestiere lo portava, di cui non conoscesse storia, usi e costumi, ascendenze etniche, caratteristiche morfologiche delle genti. Era sì portato spesso a generalizzare e a costruire, su quelle conoscenze, discutibili teoremi di rendimento sportivo, ma molte delle sue pagine più coinvolgenti riguardano questa capacità di immergere il resoconto del fatto agonistico nel contesto ambientale. Proprio questa abilità del resto lo segnalò fin dalle primissime esperienze in Gazzetta, come redattore dell'atletica prima e dal Tour poco dopo. Sì, perché Gianni deve la sua fama principalmente al calcio, ma molto ha scritto di altre discipline sportive, approdando a grandi livelli di competenza anche in settori di cui in partenza sapeva ben poco. "Non lo conoscevo nemmeno quando cominciai", confessò tra le lacrime negli studi rai di corso Sempione, quando lo chiamammo a ricordare Consolini nel giorno della scomparsa. E all'atletica rimase sempre molto legato, conscio che i relativi studi giovanili gli giovarono anche nelle successive esperienze giornalistiche. Viene riportato il suo resoconto sulla grande sfida olimpica tra Ben Johnson e Carl Lewis ed è davvero emozionante leggere quel che Brera ne ha scritto, cavando fuori da una gara durata meno di 10 secondi un pezzo incredibile, con un'infinità di motivi, emozioni, analisi comparate. Si incazzò di brutto, Gianni, quando il giorno dopo venne a sapere che quegli istanti di magia agonistica e muscolare erano stati cancellati dalla piaga del doping. Restano poi esemplari i racconti giornalistici legati al Tour, puntuali nel resoconto del fatto sportivo, ma arricchiti dalla suggestione del viaggio nella caldissima e dolce Francia. Sfilano città, castelli, luoghi di storia, cantine e osterie odorose per la favola del vino e del cibo, miraggi di irraggiungibili telefoni, pianure interminabili e minacciose salite. Il ciclismo insomma non come semplice ordine d'arrivo. Per dire le cose a quel modo bisogna conoscere. E per conoscere bisogna aver studiato. Ma Brera non si accontentava di accumulare nozioni sui libri, sapeva immergersi nei luoghi che visitava: l'ho capito una prima volta quando mi trovai per combinazione nel suo stesso taxi in una trasferta spagnola. Conscio che i tassisti di tutto il mondo sono espertissimi in campo sportivo, si ingraziò il "cochero" con alcuni lusighieri giudizi sul Real Madrid (Dio solo sa come facesse a sapere che non tifava per l'Atletico) e pian piano lo condusse a confidenze sulla città, i ristoranti tipici, le zone dei ricchi e dei "peones", le idee politiche personali e giù interrogando. Dopo quella lezione, quando eravamo in carovana, cercai sempre di infilarmi nello stesso taxi di Gianni, proprio per imparare qualcosa, pur temendo che lui sospettasse una mia maligna intenzione di scroccare il viaggetto. Con lui non c'era verso di pagare, era di una generosità imbarazzante. Del resto non credo che potesse esistere amministratore in grado di confutargli la nota spese. Dove andava finiva spesso per allacciare amicizie durature, se il posto era di suo gradimento. In genere si trovava a suo agio ovunque, ma alcuni Paesi non li poteva proprio soffrire: il cerimonioso e subdolo Giappone, per esempio, e lo sfuggente Messico. Ai secondi mondiali messicani arrivai qualche giorno dopo Gianni; entrato in albergo, lo vidi seduto in disparte con una brutta cera e il ghigno feroce. "Lo sapevo, non ci volevo tornare in questo posto maledetto!". E mi raccontò che, essendo stato colpito nel '70 dalla ben nota vendetta di Montezuma, si era sottoposto per quel secondo sgradito viaggio a una cura preventiva, onde evitare troppo frequenti precipitose corse al cesso. Il risultato era che da oltre una settimana non risuciva a defecare per quanto ingurgitasse di continuo tutte le porcherie che anni prima lo avevano condannato a omeriche sciolte. Non riuscii a trattenere un accenno di risata e sono sicuro che uscii indenne solo perché Gianni era troppo affranto per fulminarmi. Delle molte terre e genti visitate e conosciute Brera ha lasciato infiniti resoconti, il più delle volte in quei colloqui con i lettori che teneva su rubriche come l'Arcimatto e l'Accademia, fonte inesauribile di racconti, considerazioni, rimpatriate tra amici e occasione per liberare la sua innata vocazione allo scrivere. Sport e calcio erano lo spunto per andare, vedere, conoscere, assaggiare, annusare, respirare storia e usanze e poterle poi trasmettere ai lettori. Luogo privilegiato per assorbire tutto e poi rielaborarlo, la tavola, con adeguati commensali, è ovvio. Considerata l'assidua frequentazione di osterie e ristoranti, resta un mistero dove Gianni trovasse il tempo per documentarsi e studiare, anche perché di tutto quel che faceva, mangiava, beveva e apprendeva finiva poi per scrivere, da una parte o dall'altra. E non tutto veniva pubblicato. Tanto per dirne una, è uscito postumo, nel '97, un suo libro sul calcio veneto, scritto anni prima e poi rimasto in un cassetto, perché gli era stato commissionato da qualcuno della Regione Veneta che era stato politicamente "trombato" prima della pubblicazione. Roba da leggere tutta d'un fiato, terreno ideale per le sue personalissime interpretazioni metasportive, condotte sul filo della conoscenza storica, sociale e direi quasi umorale di quelle terre. A lettura conclusa, uno resta sbilanciato, convinto d'aver commesso fin lì errori imperdonabili nel catalogare sotto un'unica denominazione geografica veneziani, trevisani, padovani e vicentini, per non parlare dei marginali veronesi, rovigotti e bellunesi. Gianni era attento fino alla pignoleria, quando si trattava di individuare e spiegare i luoghi abitati dalla gente: non si accontentava certo delle suddivisioni artificialmente create dalle esigenze amministrative. Del resto per lui l'ombelico del mondo restava la natia San Zenone, che mai avrebbe accettato fosse confusa con qualche borgo lì accanto. Altra cosa erano pure la regale Pavia e la generosa Milano. Sapeva e voleva però riconoscere una più ampia comunanza di radici etniche e storiche tra le genti, non a caso è stato l'inventore della parola Padania, senza che ciò autorizzi ipotesi di una sua pretesa paternità leghista. Era sì uomo del nord, fiero di esserlo, ma nel suo modo personale, qualche volta magari eccessivo, sempre però indipendente e libero di pensiero. Non a caso le volte in cui lo convinsero a candidarsi alle elezioni gli andò buca, perché restava cane sciolto e non gli andava di assoggettarsi alle direttive dei maneggioni della politica. Per primo, a quanto mi consta, ha anche correttamente indicato la provenienza di Fabio Capello, chiamandolo "Gran Bisiaco". Fa sorridere la constatazione che oggi Capello viene definito da tutti friulano o, ben che vada, giuliano: evidente esercizio di prudenza perché chi parla, scrive, ascolta o legge non ha la minima idea di chi diavolo siano i "bisiachi". Brera lo sapeva e se, caso mai, qualcuno gli chiedeva delucidazioni era pronto a spiegare chi sono, dove abitano, come parlano e da dove vengono fuori i membri di questo apparentemente misterioso ed esiguo popolo. La solita imprevedibile conoscenza di territori e isole etniche minuscole e lontane. Arrotondava il suo sapere attraverso la conversazione spicciola, stuzzicando sempre i commensali a raccontare storie ed esperienze dei luoghi d'origine. Quanto più dissacranti e in contrasto con la storiografia ufficiale erano le testimonianze, tanto più si divertiva. Del resto non c'è angolo d'Italia nel quale non esista a livello di tradizione orale qualche fatterello che mal si concilia con la versione dei fatti riportata dai libri di testo. Nel sud come nel nord, e Brera amava rivisitare e raccontare la storia del nostro Paese attingendo a queste informazioni, meglio se avevano il sapore dell'aneddoto. Ascoltava e scriveva, sempre. Anche allo stadio. Quasi pauroso che gli sfuggisse qualche sensazione immediata, riempiva il taccuino di note, spunti, osservazioni per poi elaborarle nel rispetto della prima impressione. Per questo, soprattutto negli ultimi anni, faceva sedere accanto a sé un collega di fiducia, caso mai gli scappasse qualche fase di gioco mentre prendeva gli appunti. Il privilegio di stargli accanto era di pochi: gli esclusi, invidiosi, mormoravano contro il cavalier servente di turno. Fin da giovane, Brera si era fidato solo della parola scritta, fosse pure uno sgorbio frettoloso. Siccome di parole ne usava e manipolava molte, divenne poco a poco inventore di nuovi vocaboli e coniò folgoranti nomi di battaglia per gli atleti che lo meritavano o che stuzzicavano la sua fantasia. Ecco allora Gigi Riva "Rombo-di-Tuono", quasi incarnazione dell'eroe romantico stile Sturm und Drang; Boninsegna "Boninbagonghi" con riferimento a un famoso nano forzuto; Pasinato "Gondrand", ditta di autotrasporti nota per i suoi monumentali tir. Non sono che alcuni esempi, prima o poi qualcuno dovrebbe buttar giù un elenco completo, roba ghiotta. Celeberrimo il suo "abatino" riferito all'inizio al solo Rivera e poi esteso a tutta la categoria dei gocatori ricchi di talento più che di muscoli: alla fine Brera e Rivera ci marciavano sulla diatriba scatenata da quel termine, alimentando ad arte la sensazione di una presunta reciproca antipatia che in realtà non esisteva. Anzi, il Gianni di San Zenone nutriva sincera stima, non solo pedatoria, per il suo omonimo "mandrogno". Ma non poteva certo disconoscere le proprie convinzioni per cui il calciatore aveva da essere dotato di una certa fisicità, propensione alla corsa, al contatto, al sacrificio tattico. Quando Rocco lo rimproverava "no sta tocarme el bambin de oro", Brera gli ricordava il primo giudizio espresso proprio dal tecnico triestino sul futuro campione: "El presidente gà comprà un muleto per vederlo palegiar nel suo giardìn". Poi Rivera ebbe modo di cancellare alla grande i dubbi originari di quei due stagionati brontoloni. Il giudizio categorico era comunque una caratteristica breriana, con inevitabili risentimenti da parte dei colpiti. Ma se ne curava ben poco, convinto che, in ogni caso, fosse importante far sentire la propria opinione, esprimere i propri convincimenti. Sul linguaggio di Brera, maturato in campo sportivo e poi utilizzato anche nei romanzi, si è molto scritto e discusso. Il testo su cui la critica letteraria ha fissato in prevalenza l'attenzione è Il corpo della ragassa, singolare opera in cui i risvolti autobiografici adombrati dal'io narrante riguardano più che altro il territorio e la mentalità diffusa nella Bassa, non le vicende personali. Era uno spasso sentire Brera quando sacramentava a tavola contro quelli che disegnavano dotti accostamenti tra la sua prosa e quella, per esempio, di Gadda. Scrisse in termini molto urbani: "Non rivendico parentele di sorta con quel grandissimo intarsiatore di parole toscane riplasmate in lombardo che è zio Carlo Emilio", ma si tratta di precisazione assai edulcorata rispetto alle filippiche cui si abbandonava quando della faccenda parlava a ruota libera. Il fatto è che lui voleva far intendere come i lombardismi (e i riferimenti comprensibili e non banali a qualsiasi altro dialetto) fossero una ricerca di freschezza espressiva, di originalità insostituibile. Esattamente il contrario di quanto aveva fatto Gadda il quale, emulo di Manzoni, un altro che Brera non poteva soffrire, era andato in riva all'Arno a purificare la lingua, prima di rielaborarla con meditate iniezioni di localismi lessicali. Lo infastidiva anche chi trovava da ridire sulla struttura e sulla costruzione dei suoi romanzi, quasi a rimproverargli una troppo sbrigativa elaborazione: "Sono uno scrittore soffocato dall'attività giornalistica" amava ripetere, abituato com'era a scrivere di getto, secondo vena e ispirazione ritenute tanto più credibili in quanto immediate e spontanee. Ostentava insomma disinteresse assoluto per quel che dicevano dei suoi scritti i critici letterari, ma un po' gliene doveva importare, altrimenti non si capisce perché se la prendesse tanto. Può anche darsi che abbia avuto qualche volta in animo di fare solo lo scrittore, sacrificando alla letteratura l'originaria vocazione giornalistica: ma era giornalista e sportivo dentro, mai gli sarebbe riuscito un simile tradimento. A parte il fatto che, dicano gli altri ciò che vogliono, riuscì ad essere contemporaneamente questo e quello, giornalista e scrittore. Più terra terra, molto si discusse anche sul tifo calcistico del Giôann. Si professava del Genoa, ma ai più il Vecchio Grifone sembrava una specie di squadra specchio, dietro la quale nacondere il vero oggetto della sua fede pallonara. "Dice così per non confessare il suo tifo per l'Inter", berciavano i milanisti, mentre i cugini della beneamata sostenevano l'esatto contrario. Quasi che, pavidamente, Brera temesse di inimicarsi una parte dei suoi lettori. Sospetto a dir poco curioso, visto che di lui tutto si potrà dire ma non che avesse la tendenza a nascondere le proprie idee: spiegava che, essendo stato accolto e ben nutrito dalla generosa Milano, era contento allo stesso modo quando l'una o l'altra squadra meneghina vincevano. Bestemmia di quelle grosse per i tifosi "veri". L'ho sempre ritenuto sincero, anche se poi lui stesso mostrava di creder poco alle mie esibite predilezioni calcistiche: passi per il Grande Torino (chi non era stato stregato da quei campioni?), ma gli sembrava poco credibile che potessi fare contemporaneamente il tifo per la Triestina e per l'Udinese, ben conoscendo i pessimi rapporti tra i "cittadini" giuliani e i "contadini" friulani. Tra i due mondi però Gorizia e il suo territorio hanno sempre fatto da cuscinetto, gli ricordavo. Per la verità più "contro" che "con" Trieste e Udine, ma io ho sempre avuto un carattere accomodante. Gianni accettava invece di buon grado che mi uniformassi alla sua scelta di condivisa simpatia verso le due squadre milanesi: lui però sospettava che pendessi un po' più dalla parte del Milan (almeno finché c'era Rocco), io che lui scivolasse verso il nerazzurro (almeno finché c'era lady Erminia). Forse avevamo ragione tutti e due. Di sicuro le predilezioni per gli uni non escludevano la simpatia per gli altri. Da parte sua e mia. Questioni di tifo a parte, Giôann amava davvero il calcio, quello giocato, ben s'intende. E di quello gli piaceva parlare e scrivere, la partita era e doveva restare il centro motore di tutto il resto. Aveva intuito il rischio che il prima e il dopo, con l'inevitabile marea di chiacchiere, baruffe, sospetti, bugie, scuse, interessi extratecnici e dietrologie assortite, potevano soffocare l'essenza del gioco più bello del mondo. Non ha fatto in tempo a vedere fino a qual punto sia giunto il processo degenerativo, ma ne aveva indicato i pericoli. Approdato a Repubblica, che inizialmente non prevedeva lo sport al lunedì, lamentava di dover soltanto filosofare sul calcio, mancandogli il riscontro reale e immediato della partita, percepita come ineliminabile rito di quella religione sportiva che è il calcio. Chissà cosa direbbe oggi che la partita è diventata quasi un "optional", una scusa per poter poi innescare l'infinita cagnara dialettica. Certo è che, magari tirando martellate, si sarebbe ritagliato un suo personale spazio, con quella singolare capacità di adattamento che lo aveva portato a disimpegnarsi con identica disinvoltura nei più svariati campi dello scrivere: all'ufficio stampa dei paracadutisti o dei partigiani, sulle piste di atletica o sulle strade del tour, negli editoriali da direttore o nei fantasmagorici Arcimatto. Uomo legato alla tradizione e al culto della parola scritta, Gianni seppe accettare l'avvento della televisione, che avvertì subito come causa di grandi trasformazioni giornalistiche, senza però drammatizzarne gli effetti. Le innovazioni tecnologiche, per quanto possibile, non lo coinvolgevano più di tanto, alla silenziosa tastiera del computer o della macchina per scrivere elettrica preferì sempre il battito amico della Lettera 22, ma comprese che con la televisione, anche se all'inizio meno potente e prepotente di oggi, bisognava fare i conti. Lo stesso racconto della partita doveva diventare meno legato alla cronaca, più meditato e di commento. Non fu un gran problema per lui: di cose ne sapeva molte e sapeva soprattutto come raccontarle. Non era tra l'altro un abituale frequentatore delle sempre più affollate, e quindi inutili, sale stampa, ma risultava documentatissimo, le sue fonti informative erano svariate: curava in modo particolare l'amicizia con fotografi a bordo campo, massaggiatori e magazzinieri. E così riusciva spesso a dare qualcosa di nuovo, di fresco e originale ai suoi lettori. Serviva, ancor più di prima, a sostenere l'urto della tv che, con la potenza dell'immagine, propone subito i fatti, ma al tempo stesso li banalizza, eliminando la suggestione del racconto attraverso la parola. Pur avendo superato alla grande le esigenze di sopravvivenza immediata legate al famoso lesso, restò sempre attento a procurarsi anche il companatico e non tardò a scoprire che i vantaggi legati alla figura dell'ospite o esperto televisivo superavano la noia della presenza negli studi. Venne qualche volta anche alla rai, ma preferiva bazzicare altre contrade catodiche più remunerative. Quando arrivava in corso Sempione si chiacchierava un po', per ingannare le attese della messa in onda e per il gusto di fare un po' di maldicenza spicciola su questo o su quello. Esercizio che costituisce il substrato obbligatorio di qualsiasi conversazione tra addetti ai lavori. Non si può certo dire che trasudasse entusiasmo per queste comparsate, a superare le sue costanti perplessità giovava solo l'entità della "marchetta". Così definita per assonanza non certo casuale con il prezzo dell'amore a pagamento un tempo esercitato in luoghi all'uopo allestiti. Consolante era anche la certezza che, esaurito l'impegno, si sarebbe finiti in qualche ristorante a litigare sui vini e a stabilire gerarchie improbabili sul valore di questa o quella cucina regionale. Al proposito Gianni Brera era categorico: quella lombarda, se fatta a modo, superava tutte le altre. Affermazione forte ma surrogata da tale ricchezza di argomentazioni da mettere in difficoltà chiunque fosse tanto temerario da contraddirlo. Lo mandava in bestia l'ovvio rilievo che la ristorazione milanese, soprattutto a quei tempi, era monopolio degli osti toscani: sacramentava allora sulla pirlaggine dei lombardi, tracciando feroci analisi comparate sulle vicende milanesi di cucina e di giornalismo. Pochi gli osti meneghini, nessun direttore di testata, e tutti i lumbard a subire senza resistenza questi processi di progressiva peninsularizzazione. Qualche volta sul finire della serata, meglio della nottata, si giocava anche a carte, al Giôann piaceva la briscola, magari quella chiamata, poca predilezione invece per la scopa, ad assi o meno che fosse. Se c'era Rocco imperava il ciapa no, scelta obbligata per un difensivista come el paron. In ogni caso stare a tavola con Brera era un vero piacere e mi resta il rammarico di aver partecipato poche volte alle famose riunioni del giovedì, di cui, a supporto di quanto Brera ne scriveva, avevo ragguagli da Peppin Viola che invece era ospite più assiduo. Mi lusingava il fatto che proprio a lui talora Gianni chiedesse informazioni su di me. Viola, fratello più che collega, amava ricamarci su: una volta, per sottolineare quanto fossi pigro, gli disse che la mia massima aspirazione era diventare il miglior giocatore di boccette del rione in cui abitavo. Bugia grossa, naturalmente, visto che in realtà volevo diventare il numero uno dell'intera zona sei. In ogni caso quei due avevano capito che, per quanto facessi il mestiere con ovvio diletto, non potevo certo dire di aver sentito la chiamata al giornalismo: mi ero trovato lì per caso, contentissimo di fare una cosa che mi piaceva essendo anche retribuito, ma per nulla arso dentro da quel che si dice il sacro fuoco della vocazione. Ho sempre sospettato che mi ritenessero un po' strano, per non dire fuori di testa, ma non me la prendevo, tanto regolari dopo tutto non erano nemmeno loro due. Ci sarebbe ancora molto da dire sul Giôannfucarlo: cacciatore come tutti infallibile nei racconti, o esperto per antico sapere familiare a catturar pesci con le mani, o promettente calciatore selezionato nella rappresentativa dei boys milanesi. Risistemano il tutto con un po' d'ordine Paolo Brera e Claudio Rinaldi con il costante contrappunto degli scritti, molti inediti, attraverso i quali il Nostro ci fa l'occhiolino, capace di dare il senso dell'avventura a qualsiasi vicenda gli capitasse di comunicare. Assume così il sapore della saga familiare la narrazione della prima giovinezza a San Zenone, tra sogni e stenti, con la figura di padre Carlo potenziale grande atleta, roba che, se i tempi fossero stati maturi, magari diventava un campione di quelli grossi. Saltatore in lungo, in alto, gran nuotatore: bastava che ci avesse provato sul serio e con il giusto stile. Sull'argomento tuttavia Gianni non poteva pretendere l'esclusiva: chi di noi non ha avuto qualche parente che se solo fosse nato un po' dopo... Mio padre, per esempio, era un autentico fenomeno nel tiro alla fune. A ciascuno di noi piace illustrare in qualche modo ascendenze di un certo rilievo: Gianni poi poteva parlare dei Brera, magari diventati ramo povero di una gens famosa, ma pur sempre Brera, che diamine! Si affollano i ricordi e uno li butta giù così, alla rinfusa. Comunque la si rigiri, va a finire che ci riscopriamo tutti e più che mai dei "senzabrera", per dirla con Gianni Mura, allievo tra i prediletti. Caso mai qualcuno, ipotesi poco probabile, avesse cominciato a dimenticare, gli autori provvedono a ricompattare il popolo dei breriani. Sono aperte le iscrizioni anche ai giovani che non lo hanno conosciuto e letto. Benvenuti.
|
||||||||
|
Nel nome del Po Il mio vero nome è Giovanni Luigi Brera. Sono nato l'8 settembre 1919 a San Zenone Po, in provincia di Pavia, e cresciuto brado o quasi fra boschi, rive e mollenti. Ricordandomi seminudo con altri coetanei nelle acque della materna Olona, allora fresca e verde non meno degli altri bei fiumi lombardi, ho talora un brivido che sta fra il rimpianto e la paura. Il rimpianto per quei giorni di beata e quasi animale incoscienza di noi e della nostra solida povertà; la paura si rifà certamente a lontane memorie bio-storiche, e come l'Olona fluisce a confondersi con i terrori che il Po ci ha lasciato nel sangue. Gianni Brera Per reagire a quel brivido, mi attengo più volentieri alle rive basse di Olona, ma talvolta non escludo l'ipotesi che qualcuno di noi, fra tante oche e paperi naviganti sul fiume, sia stato cucinato per errore alla sagra di San Bartolomeo. La sagra viene a fine agosto, quando le anatre maggenghe sono giusto mature per l'arrosto. Le oche, quelle sopravvivono per la muta, che rinnova di piume candide i guanciali e le coperte trapunte; per loro si aspetta che i cavoli verzotti abbiano a fare testa, e che li renda croccanti il primo gelo: allora a punto anche il vinello dei nostri ultimi filari: i ragôt di oca riempiono di acquoline alemanne i prodi rivaioli di Po. Tale premessa considero doverosa per il lettore nuovo, che non mi confonda con gli agiografi d'occasione, con gli economisti e i geografi ai quali tanto piace affondare nei nostri sabbioni almeno fino alla caviglia, nelle nostre fanghe di lanca fino al ginocchio et ultra, così da dover subito chiedere aiuto. E si capisce che poi mutano registro. Il fascino del gran fiume gli si confonde in cifre e dispetto. I suoi gorghi assassini, i parioeu - o imbuti - si dilatano in vortici spaventosi. Le voci antiche si incupiscono di leggende sgradevoli o addirittura macabre, orripilanti. Per le sue rive larghe e ineguali, il fiume appare a loro, i foresti, una selvaggia e inconoscibile correntia di umori precariamente instabili, ora come placata ma infida negli slarghi, ora furiosa di impeti balzani e inutili, anzi dannosi. Nossignori: io sono padano di riva e di golena, di boschi e di sabbioni. E mi sono scoperto figlio legittimo del Po, in aperta contraddizione con il Diritto Romano, per il quale mater semper certa, pater numquam. La mia sicurezza filiale viene dal complesso edipico nei confronti del padre. Non esiste infatti padano vero nel cui sangue non si perpetui il timore e quindi l'odio per il gran fiume. Gli amori e le estasi agiografiche sono vezzi di terricoli con i piedi ben al sicuro. Chi ha soltanto immaginato uno dei suoi nelle acque profonde e impetuose del fiume non può dire di amarlo. Chi l'ha sentito rombare nelle notti di piena non può non temerlo. Chi l'ha visto erodere a poco a poco i suoi campi e si è ritrovato povero dopo gli stenti le fatiche le vittorie di intere generazioni, sente che al fiume padre si rifà la sua sorte nel bene come nel male. Il senso panico gli sopravvive nel sangue come l'angoscia che fu dei suoi avi e ancor oggi è sua. Il Cristianesimo gli ha insegnato a escludere, secondo logica, che si tratti di un nume, un iddio da venerare e da temere: ma l'invenzione mitica e pagana era soltanto di comodo, trasposizione religiosa che consentisse anche ragionevole scampo dalla paura, dal travaglio continuo per resistere e non morire. Il Po ha fatto ricchi e poveri a migliaia di migliaia. Ogni famiglia padana è stata agiata o miserabile secondo che il fiume ha voluto nelle sue piene cattive, nel suo subdolo tentennare da riva a riva. Il Po è traditore, come mi hanno insegnato a pensare fin da piccolo. Andare a nuotare in Po significa farlo a proprio rischio e pericolo. Il rivaiolo padano diventa vir agli occhi dei suoi paesani se riesce a traversare Po e tornare nuotando. Nei suoi vizi osteo-muscolari è evidente l'influsso diverso delle rive: chi sta sulla sinistra punta il remo per risalire manovrandolo contro il bordo destro del suo battello, chi sta sulla destra lo manovra sul bordo opposto. Le forcole sono ricavate da due rami di robinia o di salice divaricati. I battelli sono di rovere stagionata e obbediscono a norme idrodinamiche la cui memoria si perde nei secoli, forse nei millenni. La gondola veneziana è la sublimazione cittadina e mondana, diciamo edonistica, del battello padano. Chiunque sia nato sul fiume e non ne sia scappato per tempo sa remare vogando e sciando come i veneti. La sola complicazione è data dalla forcola, che nella gondola di metallo a più appoggi non ricurvi ("perché altrimenti, mi ha spiegato un gondoliere, tutti sarebbero capaci di remare come noi"). Personalmente ho attraversato Po a dodici anni e mi sono affidato alla corrente con altri non coetanei che mi hanno subito avvertito come, in caso di malore, nessuno si sarebbe fermato per aiutarmi; la stessa cosa avrei dovuto fare io se fosse stato un altro ad avere una congestione o anche semplicemente i crampi nei polpacci. Questo preciso accordo era tradizionale in Padania e mio padre mi ha confermato di esservisi attenuto quando è toccato a lui di attraversare Po. Ovviamente, giovava a rendere emblematico un atto di normale coraggio. La nostra tecnica natatoria era molto rudimentale. Gli stili di nuoto erano tre soli: a cagnón (come cani); a sguilz (a guizzi), cioè a spalletta; alla marinara (con le due braccia alternate fuor d'acqua e la spinta a forbice con i piedi). Nessuno che sapesse nuotare soltanto a cagnón ha mai osato attraversare Po. Riposante e abbastanza redditizio era lo stile a spalletta, un braccio sempre teso a sostegno, uno portato fuori a tirare acqua, i piedi azionati a forbice come nella marinara. Il crawl sarebbe venuto più tardi, con i ritorni estivi degli studenti. Già lo stile alla marinara (over) consentiva notevole velocità. In caso di stanchezza, era sempre agevole rifugiarsi nello stile spalletta, secondare la corrente e toccare l'altra riva a distanze talora impressionanti. Ho detto che si passava a far parte dei viri (anticamente, che so?, dei guerrieri) attraversando a nuoto il fiume e ritornando quasi subito alla riva natia. Nuotare in Po era bullaggine che il crawl ha dimensionato notevolmente. Io parlo dei miei tempi e non esito a credere che tutto sia cambiato con la crescente diffusione del nuoto come sport agonistico. Nei nostri ricordi bio-storici, il Po è rimasto come un nume bizzoso e incostante, perciò traditore. Chi non vi è nato non sa distinguere un mollente all'inizio dello scalone. Il fiume porta costantemente sabbia rubata all'una o l'altra riva. Il filo - o Tahlweg - della sua corrente può durare per anni o pochi mesi. Il canale formato dal filo è profondo da quattro a dieci metri secondo altitudine, cioè secondo distanza dalla sorgente e dal mare. Quando il filo di corrente si urta a un tratto di riva non cedevole come altri, solitamente ne viene respinto in un inquieto ribollire di acqua, di vortici e onde maligne: quasi subito il canale di Po si sposta con il filo: nel fondale precedente si deposita sabbia: l'acqua è bassa fin dove si forma scalone: oltre quello, si placa in un mollente che può essere esteso tanto da sfiancare qualsiasi nuotatore malpratico. Dalle mie parti, quando annega uno, si dice che è annegato un milanese o un muntagné (cioè uno di collina). I Padani annegano meno perché in effetti arrischiano poco. La loro paura antica si trasforma in prudente ritegno. Eppoi conoscono i mollenti; sanno dove li può sorreggere il filo e dove non li aiuterebbe invece l'acqua morta. Anche in battello i padani hanno paura. Mio nonno paterno è annegato rovesciandosi dal bordo di un battello che lo portava, ebbro, da Arena. Per quanto bullo fosse mio padre - e un poco lo era - non l'ho mai visto prendersi troppe confidenze quando remava sul fiume. Alcuni ghiaiadori suoi coetanei mi hanno addirittura stupito per la fifa - non si trattava di altro - che li prendeva quando mettevano piede su un battello non molto largo di fondo e quindi geloso, cioè sensibile al minimo peso sui bordi. I ghiaiadori solevano imbarcare sabbia o ghiaia sulle proprie maone fino a lasciarle fuori appena due-tre dita di bordo. Sarebbe bastata la minima ondicella a mandarle a picco: tuttavia i ghiaiadori manovravano le loro grevi imbarcazioni senza il minimo patema: essi invece sfioravano il ridicolo (a me pareva) quando lasciavano la maona per uno di quei battellini da diporto che usavano i cittadini. Riflettendoci meglio, ho creduto di capire che l'antico rispetto seguitasse ad agire in loro quando solcavano il Po per proprio esclusivo piacere e non per lavoro. Insomma, divertirsi remando in Po gli pareva quasi sacrilego, e non temevano di manifestare la loro venerazione per il Nume traverso quelle confessioni di paura che a me tornavano tanto sorprendenti. Del resto, la stessa paura, diciamo pure la stessa superstizione, se di questo si tratta, si è andata manifestando in me con l'aumentare degli anni. In molte occasioni ho ironizzato sul Po e i suoi estri di padre ubriacone: troppe colline da vino, avevo scritto, lambisce il gran fiume per non avere la piena, pardon, la sbornia cattiva. Era sicuramente un modo di uscire d'angoscia ironizzando (io m'illudevo!) sulle nostre stesse paure dei ghiaiadori coetanei di mio padre. Quando i miei figli imbulliscono nuotando dove io pure ho nuotato, mi spavento. Qualche volta ho il sospetto che solo nel raggiungere la riva, qualche altra di aver rischiato appoggiandosi a una chiatta muschiosa, sotto la quale passava di traverso la corrente: come dire: non ti disprezziamo, hai perfettamente ragione di rispettare Po...
Gianni Brera: il suo stile, di Paolo Brera Di Gianni Brera si menziona spesso lo stile, scordando, forse, quella che era la sua posizione autentica: cioè che lo stile è secondario rispetto a ciò che si raccontava. È in queste chiave che cercherò, nelle prossime righe, di dare conto dello stile e di alcuni risvolti dell'opera di Brera e della sua considerevole personalità. Lo stile precipuo di Gianni Brera viene a maturazione negli anni in cui è direttore della Gazzetta dello Sport, cioè dal 1949 al 1954. La direzione della Rosea del resto è in molti sensi l’avvenimento cruciale della carriera di Brera. Scrivere di sport, e scriverne liberamente, ne porta a termine la maturazione anche letteraria. Già che il direttore scrive come vuole lui; e gli altri, anche (nel senso che essi pure devono scrivere come vuole il direttore). Tenendo le redini del quotidiano sportivo, Brera è in grado di elaborare e di esprimere compiutamente, senza più doversi inquietare di piacere a capiservizio o capiredattori, la sua concezione difensivista del calcio. Nel difensivismo di Brera confluiscono con ogni probabilità diverse esperienze: da quella del centravanti innamorato del gioco inglese a quella del partigiano che sa di dover sempre giocare in difesa: il contropiede del gioco all’italiana assomiglia un po’ al "mordi e fuggi" della tattica garibaldina della guerriglia. A tutto ciò si aggiungono le conoscenze tecniche e fisiologiche maturate nello studio dell’atletica: se manca il vigore, ragiona Brera, è impossibile giocare tutto sull’attacco: la prima guerra mondiale, come icasticamente dirà più tardi il giornalista, non si sarebbe potuta vincere semplicemente decidendo di marciare senz’altro su Vienna. Dunque squadra disposta a catenaccio, pronta al contropiede: due espressioni chiave che si cominciano a sentire appunto nei primi anni Cinquanta. La prima nasce come designazione spregiativa ma viene poi assunta e fatta propria dai difensivisti; la seconda descrive, nella visione di Brera, la ragion d’essere del quid designato dalla prima. Primo comandamento, non prenderle: mica puoi perdere se non lasci segnare i gol all’avversario; e se quello si sbilancia in avanti per provarci contro la tua difesa ultra-agguerrita, quando perde la palla non ha più fra la suddetta e la porta chi possa bloccarla prima della fatale estrema riga di gesso della sua metà campo. Semplice come la lotta fra il Bene e il Male nei film western dello stesso decennio, e altrettanto appassionante, almeno per chi s’interessa di calcio (il 90 per cento della popolazione maschile). "All’inizio ero così compreso dei miei doveri che senza volere assumevo uno stile aulico, diciamo quasi di maniera crociana, che almeno si accorgesse il lettore di come io prendevo sul serio lui, il calcio e il mio mestiere!" ( dallo scritto "Interpretazione critica di una partita di calcio", pag. XVII). Le cronache calcistiche di Brera si distinguono per le analisi tecniche, allora ben rare e approssimative negli scritti di altri, e per lo stile che si viene elaborando proprio in quegli anni. "Il giornalismo calcistico non aveva neppure un linguaggio suo", scriverà Brera parecchi anni più tardi, rievocando quel periodo eroico: "molti termini inglesi erano espressi con perifrasi alla lunga tediose e stucchevoli". Toccherà appunto a Brera introdurre nella nostra lingua i termini necessari per parlare di calcio. Molte delle espressioni tecniche del gioco hanno origine appunto nelle pagine del cronista. Ma anche al di là dei tecnicismi, la sua strabocchevole creatività linguistica fa di Brera uno dei grandi del secolo XX. Il dialetto, la lingua arcaica, gli idiomi stranieri e i neologismi hanno intessuto gli scritti di Brera come di nessun altro. Tullio de Mauro ha osservato che a partire dal dopoguerra i dialetti, da sempre vivissimi nella penisola, subiscono un'erosione crescente da parte della lingua letteraria, erosione che potrebbe essersi arrestata solo negli ultimi anni. Dopo il 1945 gli àmbiti comunicativi in cui è appropriata la lingua nazionale (per dirla con Wittgenstein, i giochi linguistici in cui compare l'italiano) si vengono espandendo. Il bilinguismo si diffonde sempre più, il monolinguismo dei parlanti il solo dialetto diventa più raro. Parole e suoni dell'italiano trasmigrano nelle parlate locali, spesso espellendone gli inquilini originari. Séguita peraltro a incombere sulla lingua nazionale l'ombra della sua nascita troppo letteraria, staccata dalla vita (tranne in Toscana, dove però le parlate locali sono ormai non meno dialettali di quelle di altre regioni, come ha ricordato Giacomo Devoto). La lingua è più dei dialetti capace di esprimere determinate cose, ma in diversi campi è meno potente di essi e meno vivida. Di filosofia è certo più facile parlare in italiano che in napoletano o in milanese, ma è anche vero che certe immagini dialettali della vita di tutti i giorni perdono ogni immediatezza se tradotte in lingua. Ofellee, fa' el tò mestee: lo si può dire assai bene in latino (Sutor, ne ultra crepidam!) ma certo non altrettanto in fiorentinesco moscheto: "Pasticciere, fa' il tuo mestiere(?!)". Anche i dialetti, dunque, oggi contribuiscono alla lingua, e addirittura molto di più di quanto non abbiano fatto in passato. Cedono ad essa il loro normale materiale lessicale o elementi di slang all'inizio alquanto intrisi di colore locale: imbranato, pirla, marpione, pitonato, sgamare: e non è puro caso se sono tutte espressioni volgari o molto colorite, come il sedere di un babbuino (come el cuu d'on scimpantsee). Vanno perfino più in là, i dialetti: influenzano la sintassi della lingua, e anche - detto in modo più generale, anche se con minore precisione - le movenze stesse dell'italiano parlato e scritto. La struttura molto complessa dei modi e dei tempi verbali italiani, secondo è stato spiegato a chi scrive da Maité Savaré, una studiosa di lettere classiche, deriva dal fatto che il substrato linguistico della Toscana, cioè della regione che ha fatto da culla al volgare italiano, non era indoeuropeo ma etrusco. I latini si erano inventati il sistema dei modi e tempi verbali per meglio chiarire i rapporti fra i diversi eventi, il che era cruciale per fondare su basi solide il diritto romano e in questo modo organizzare la dominazione dei popoli soggetti. Ma là dove il latino si è sovrapposto a una qualche parlata indoeuropea - celtica piuttosto che italica - la coniugazione si è poi radicalmente semplificata. È riemersa, infatti, l'originaria struttura indoeuropea - la quale non va molto al di là della triade passato-presente-futuro, e talora, come nelle lingue slave, tende a confondere congiuntivo e condizionale in una specie di grande ammucchiata grammaticale. Questo comodo modello su cui ricalcare i tempi dei nuovi verbi latini mancava nelle regioni dove, prima della conquista romana, si era parlato un idioma non indoeuropeo. Per questo motivo lo spagnolo e l'italiano letterario conservano tuttora un apparato di tempi verbali prossimo a quello latino: più complesso, quindi, di quello del francese o dei dialetti italiani. Con secoli di ritardo, la vendetta di Vercingetorige si sta consumando oggi con il ritorno a una sintassi più semplice: ne è un aspetto la radicale ristrutturazione della consecutio temporum cui stiamo assistendo in questi ultimi anni nella nostra lingua, insieme all'atrofia del congiuntivo. La "trasfusione di sangue" dal dialetto alla lingua non avviene in modo indiscriminato in tutti gli àmbiti della vita sociale, né in qualunque momento. Avviene sopra tutto là dove e quando si agitano forti emozioni: giacché il dialetto è più popolare della lingua, dunque più vivo e colorito, e ad esso si ricorre quando si vuole esprimere qualcosa che in italiano apparirebbe esangue. Perché la trasfusione abbia successo occorre poi che sia a portata di mano un mezzo di comunicazione abbastanza autorevole e diffuso da estendere il nuovo uso al di là dell'area in cui è stato generato. Si può dire che il dialetto integra e arricchisce la lingua là dove questa manca di vigore espressivo, mentre al dialetto la lingua dà del suo se in esso esiste un vuoto semantico, una voragine di concetti che non possono essere richiamati in modo soddisfacente perché lo strumento "dialetto" è inadeguato. Abyssus abyssum vocat, insomma. Gianni Brera è stato un imbuto d'elezione per l'enorme travaso nella lingua nazionale di modalità espressive lombarde (ma anche settentrionali in generale) che si è verificato nella seconda metà di questo secolo. Perché è stato possibile per un giornalista sportivo svolgere un simile ruolo? Non pretendo di dare qui una risposta completa. Intenderei però fornire alcuni elementi che a me sembra facciano parte della risposta. Capo primo, Brera ha sempre operato a Milano. L'Italia, come ogni nazione, come ogni spazio economico, non è un insieme amorfo, ma un insieme strutturato, in cui emergono diversi poli. In questa realtà nazionale e socioeconomica Milano è uno dei due poli più importanti (lascio alla fantasia di chi ascolta l'individuazione dell'altro). In certo modo, è la capitale del Nord Italia, dal cui territorio si alimenta sul piano dell’economia e della popolazione. L'immigrazione dal resto del Nord e i contatti quotidiani con la val Padana, la Liguria e la Lunigiana fanno di Milano un crogiolo non solo sociale ed economico, ma anche linguistico. Nell’Italia del dopoguerra Milano è sempre stata il massimo centro dell'industria editoriale e discografica. Negli anni Settanta e Ottanta è divenuta anche uno dei poli televisivi del Paese, e ha assunto un peso maggiore anche in un mezzo - pure declinante - come il cinema. Per questo il materiale lessicale, grammaticale e sintattico che affluisce a Milano per esservi integrato alla versione locale della lingua italiana viene, in un secondo tempo, nuovamente ridiffuso in tutte le direzioni. Nel recensire su "Repubblica" il romanzo di Brera Il mio vescovo e le animalesse , Beniamino Placido ha osservato che nel romanzo le espressioni in dialetto pavese tradotte nelle note a pie' di pagina risultavano a volte ostiche, mentre negli articoli di giornale si lasciavano agevolmente comprendere senza bisogno di rimandi, perché si inserivano nel contesto in modo del tutto naturale. Placido ha abbastanza ragione. La comprensione è massima nelle cronache calcistiche. E se uno si domanda seriamente perché, ecco come deve rispondere: perché appunto in quelle, perfino nelle più tecniche, è massima la tensione emotiva; e dunque lì tocca il punto massimo anche la potenza espressiva del dialetto. Contesto milanese, contesto calcistico: Brera agisce in uno degli àmbiti più passionali della vita contemporanea, a partire da uno dei centri di irradiamento linguistico più dinamici di questo secolo. La sua personale attività creativa ne viene potenziata. L'uomo giusto, nel momento giusto, al posto giusto: e con il mezzo di comunicazione giusto. Ci stiamo avvicinando a una risposta per la domanda di prima. Brera è stato spesso accostato a Carlo Emilio Gadda, in alcuni casi perché lo si voleva ridimensionare con un confronto che si presumeva sfavorevole. Il giudizio di critica letteraria non mi compete. Mi preme tuttavia mettere in rilievo che tra i due esiste una differenza profonda: la fecondazione della lingua mediante il dialetto avviene in Brera a caldo, nel mulinello delle passioni generate dallo sport: mentre in Gadda ogni manipolazione linguistica occorre del tutto a freddo. La creazione letteraria libera da costrizioni di tempo e di soggetto ha in Brera uno spazio incomparabilmente minore che in Gadda. Il dialetto non è, comunque, l'unica chiave di comprensione del Brera artigiano (o artefice) della lingua: c'è anche l'assidua pratica del neologismo e l'uso delle lingue. Il neologismo è importante. Parole come "intramontabile" o "abatino" ed espressioni come "senso euclideo" hanno documentabile origine nelle cronache breriane; e molte altre se ne potrebbero citare. Alcune sono passate nell'uso generale, traboccando con naturalezza al di fuori dell'àmbito sportivo. Altre sono manifestazioni di uno stile personale che tale è rimasto anche nel fiorire delle imitazioni (i cosiddetti "brerini"). Il ricorso alle lingue ha in Brera una funzione poco meno importante. Francese, spagnolo, qualche po' di tedesco, misuratissimo inglese forniscono materiale che Brera incastona in un periodare pur sempre italiano-del-Nord. In ciò non diverse, tali lingue, dal romanesco o dal napoletano, se non per il differente registro delle frasi in cui si lasciano inserire. Per esemplificare: una parola comeWeltanschauung non può essere sostituita da un prestito partenopeo, né Vico (che Brera amava citare) ha mai scritto nel dialetto della sua città, pure coltissima nelle sue élites. Il latino era, insieme al francese, la lingua di cultura più consona a Brera. In Italia la cultura te la dà la media superiore, non l'Università, che tende semmai a specializzarla e parcellizzarla, a volte a un segno tale da snaturarla. Vero in generale, verissimo nel caso di Brera. Laureato in Scienze Politiche a Pavia durante la guerra mondiale, ne aveva però seguito i corsi in modo saltuario: non per scelta, certo: ma perché altrui decisioni giusto in quegli anni lo impegnavano a gettarsi armato, appeso ad un serico velo, da aeroplani in volo. Il latino di Brera era quello del liceo scientifico, attraverso il quale filtrava (temporibus illis) anche parecchio greco classico. E proprio il liceo scientifico, nel dopoguerra, era la scuola della classe media emergente, che apprezzava una reminiscenza di Orazio inserita in un resoconto sportivo e anche per questo, forse, era grata a Brera del suo volersi fare tramite fra l'istruzione e il football. Più in generale, questa considerazione si applica anche allo sfoggio di cultura letteraria e storica che così spesso si ritrova nelle pagine di Brera: per quel tanto che capisce o che ricorda, il nuovo italiano inurbato e piccolo borghese ritrova ciò che gli hanno fatto studiare nella scuola secondaria e che conserva intatto il suo prestigio. Dialetto, neologismi, lingue estere e latino: manca ancora solo un'altra delle componenti della tela di fondo su cui si staglia lo stile di Brera: quella del purismo. Nello studio in cui il Brera della maturità produceva i suoi scritti troneggiava il quasibiblico Devoto-Oli, non si contavano gli altri dizionari. E il materiale lessicale, con il significato esatto delle parole, veniva anche dalla lettura quotidiana di romanzi, saggi e racconti: le ore della notte, sorseggiato che fosse l'ultimo centilitro di Barbaresco, partito l'ultimo amico, erano dedicate alla letteratura, così come le prime ore del risveglio, a parte una tazza di tè che prendeva ancora a letto, erano sacre alla stampa periodica. Certo, nella frenesia delle cronache il ricorso metodico a tutto questo indispensabile background non era possibile: bisognava usare lì per lì quanto urgeva alla mente e alle dita del giornalista, per il quale la deadline del quotidiano è più sacra della Messa della domenica. Come dare torto a Brera, quando rimproverava a Umberto Eco di non comprendere in quali condizioni lavorasse e sempre necessariamente lavori il cronista? lui che aveva il becco di paragonare gli esagitati scritti sportivi a quelli del letterato, il quale solo ha il cospicuo privilegio di poter rifinire il proprio secreto con la dovuta calma! Il tour de force della domenica era d'altro canto preceduto dagli allenamenti linguistici della settimana. Nei giorni feriali c'era più tempo: a dire il vero, non poi tanto di più quando si trattava di scrivere: ma sì per leggere, e dunque per introiettare movenze linguistiche e stilemi da resuscitare in diligenza al dì di festa. Una volta creato e legittimato agli occhi del pubblico il suo stile, Brera non intendeva certo limitarsi a usarlo nelle sue cronache sportive. Fra cento anni, credo, queste non saranno più neppure nominate, e di lui si ricorderanno solo le opere letterarie: le tre biografie romanzate di ciclisti (Pavesi, Coppi e Campagnolo), i tre romanzi della Trilogia di Pianariva, e la commedia Mille e non più mille. In tutti questi, tranne forse la sola biografia di Campagnolo, è evidente l'importanza della dimensione locale. "In novembre, la nostra Bassa è il paese più triste del mondo. Gli alberi sono spogli. L'erba è brinata. Dai fossi e dai fiumi sale ondeggiando la nebbia. I corvi si riuniscono in branchi e indugiano sugli arati lanciando rauche strida. La gente sente venire l'inverno e senza volere incupisce. Nei suoi lavori c'è un senso di fretta ansiosa, che gli animali scontano a legnate". Con queste parole Gianni Brera introduce, a due terzi del Corpo della ragassa, il vero protagonista di questo come degli altri suoi lavori: il microcosmo sociale e geografico del Pavese, la sua terra di origine. Gli abitanti del Pavese, discendenti dei liguri levi che vivevano nella zona già prima dell'arrivo dei romani, hanno un ethos fatto di lavoro costante e ben fatto, sono semplici ma ben motivati nella ricerca dei piaceri, rifuggono dalle esagerazioni e si mostrano tolleranti verso gli altri. Se in guerra o nella vita compiono atti di coraggio hanno ritegno di parlarne, perché sospettano interessato inganno in ogni mostra di alte virtù od alti sentimenti. Nella colonna del passivo bisogna iscrivere l'invidia paesana, il rifiuto di riconoscere la grandezza di chiunque faccia parte dello stesso microcosmo, e una buona dose di classismo. E qua e là, anche la grettezza. Ormai da secoli il territorio di Pavia subisce non solo l'attrazione economica e sociale della città capoluogo, ma anche quella di Milano. A questi legami materiali e storici corrisponde anche un legame nella formazione intellettuale e culturale di Gianni Brera. Il microcosmo della Bassa pavese è il punto di partenza e la chiave più sicura per ogni interpretazione profonda della sua anima; Pavia è il luogo dell'elaborazione, dove le più caratteristiche tendenze interiori si decantano; e Milano è l'arena in cui alla fine Brera scenderà, da giornalista e scrittore, con in resta la lancia polemica che gli conosciamo. Vistose tracce di questo legame fra le tre aree, così come si presentava negli anni Venti e Trenta, sono presenti sopra tutto nel romanzo Il corpo della ragassa. La bassaiola Cecchina, detta anche Le Disgrazie del Vizio, per legarsi con un balordo è andata a Milano, né avrebbe potuto andare altrove; Pavia è la città dietro l'angolo, dove si gode di una maggiore libertà d'azione ma pure si deve mantenere una certa cautela; e San Zenone al Po, che nel romanzo compare con il suo vero nome e non con quello, Pianariva, dei romanzi successivi, è il villaggio rurale, arretrato e limitato, dal quale a tutti i costi occorre emanciparsi. In esso per Brera ci sono anche valori positivi: è sicuro: ma bisogna necessariamente vederli in controluce, perché su quelli lui dirà sempre ben poco di esplicito. E nei romanzi, niente. Anche questo, del resto, fa parte del carattere pavese. In altri scritti la valorizzazione della pavesitas è invece più che esplicita: dove si parla di cibi e di vini, di tradizioni popolari, di cultura locale. Però questo campanilismo non era cieco e sordo di fronte alle tradizioni degli altri, ai valori di aree diverse dalla sua. Brera è stato un grande interprete di tutto questo in tutte le aree geografiche in cui si è mosso: in Lombardia e nel Nord Italia più che nel resto del Paese, ma non unicamente in Lombardia o nel Nord Italia. Lo scrittore lombardo ha amici in Sardegna, in Sicilia, in Toscana, a Napoli, nel Lazio: non gliene conosco a Bari o in Lucania, ma dev'essere un caso o una carenza informativa di chi scrive. Io credo che, nella cultura e nella vita, Brera sia stato un buon esempio di un modo regionale di essere italiani. Ma per essere più preciso, mi domando se esistano poi altri modi, diversi da questo, di essere italiani. |
||||||||
|
||||||||
